Roma FF11 – Haiku on a Plum Tree: recensione
Presentato nella sezione Riflessi di Roma FF11, Haiku on a Plum Tree (Haiku sull’albero del prugno) è il viaggio personale di Mujah Maraini-Melehi.
Presentato nella sezione Riflessi all’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Haiku on a Plum Tree (Haiku sull’albero del prugno) è il viaggio personale che la regista Mujah Maraini-Melehi compie alla ricerca dell’eredità storica che la famiglia Maraini ha lasciato, dietro di sé, durante la sua prigionia in Giappone negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
La voce narrante è quella della stessa Mujah e ripercorre gli eventi principali che segnano il percorso di Topazia Alliata insieme a Fosco Maraini, ricordando il 1938 come il momento cruciale che marca per sempre un prima e un dopo indelebili nella vita dei due innamorati. È in quell’anno, infatti, che Topazia e Fosco decidono insieme di lasciare l’Italia del fascismo per imbarcarsi alla rotta del Giappone, alla ricerca di un’isola felice in cui coltivare i propri sogni e i propri interessi comuni e individuali.
Una scelta che i due, invece, compiono separatamente (sottolineando ancora una volta la grande intesa che costituiva le vere radici del loro rapporto) è quella di non firmare per la Repubblica di Salò nell’8 settembre del 1943, decisione che li condanna irreversibilmente a due anni all’interno di un campo di prigionia giapponese insieme ai loro figli Dacia, Yuki e Toni, gli unici bambini lì presenti.
Haiku on a Plum Tree: il viaggio di Mujah Maraini-Melehi tra guerra e famiglia

Mujah ricalca le orme del viaggio di Topazia e Fosco recuperando le parole e i pensieri che la donna annotava su Love Holiday, diario ingiallito preparato e tenuto da parte per parlare di quelle che dovevano essere le vacanze d’amore dei due protagonisti, e che finisce per essere solo la testimonianza di un incubo incancellabile.
A parlare, però, è anche la stessa Topazia che risponde alle domande di Mujah e narra in prima persona l’esperienza come unica donna all’interno del campo, ricordando in particolar modo e in maniera lucidissima ogni aneddoto e ogni piccola tortura psicologica cui era sottoposta e che, oggi, definisce trauma. Fotografie e video di repertorio contribuiscono a immergere totalmente lo spettatore non solo nella storia privata di Topazia e Fosco, e non solo anche nell’attuale viaggio appassionante (e appassionato) di Mujah, bensì, soprattutto, in un’epoca passata rievocata dalle immagini consumate che passano sullo schermo e, ad accompagnarle, dalla melodia di un pianoforte lontano nel tempo a fare da “colonna sonora”.
A family tree is made of choices: Japan is part of me, and traveling is in my blood.
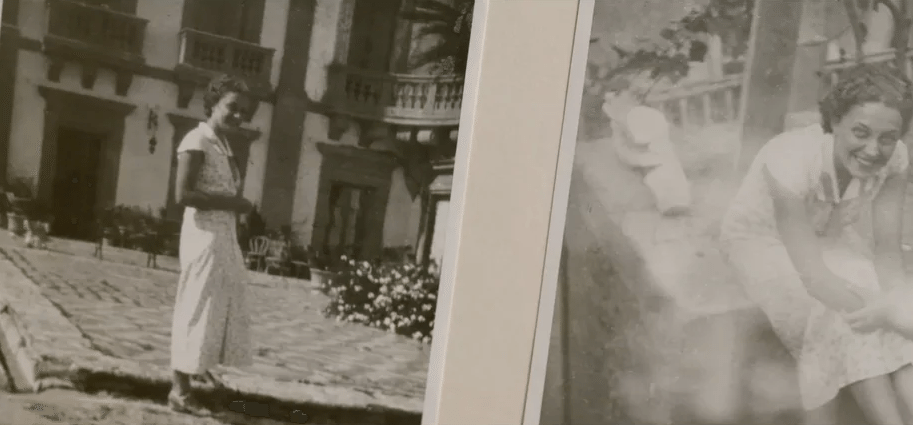
Mujah riconosce quel Giappone nel proprio sangue e nelle proprie origini familiari, come elemento basilare dello stesso albero genealogico in cui compare il suo nome e quello dei propri nonni.
È qui che il contrasto con le parole finali di Topazia, una volta attratta dalla stessa terra ma ora traumatizzata e del tutto distante dall’idea di rimettervi piede, si fa più evidente: tramite il confronto delle personalità appartenenti alle due donne, il viaggio diviene generazionale e non più solo personale. La regista, inoltre, finisce con l’abbracciare totalmente la cultura e la tradizione del Giappone narrando la storia della propria famiglia mediante un teatro d’ombre orientale, in cui Topazia e i propri figli divengono sagome mobili poste in controluce su meravigliosi sfondi opalescenti.
La tragedia si trasforma in fiaba a lieto fine. Tuttavia, a lasciare vagamente interdetti è il tentativo di drastica e perentoria censura degli episodi e dei momenti più difficili che hanno portato Topazia a essere la donna che è oggi, atterrita e malinconica – seppur tenti di celare il proprio stato d’animo – davanti alla macchina da presa: se, da una parte, è da ammirare l’impresa tramite cui Haiku on a Plum Tree rifiuta di categorizzarsi come ennesima messinscena di uno spettacolino degli orrori è anche vero che, per raccontare il brutto trasformandolo in bello, Mujah trascura ogni aspetto psicologico che è parte fondante del trauma di Topazia (come, ad esempio, l’indagine sull’esistenza o meno di quel senso di colpa che potrebbe essere scaturito dall’aver trascinato i propri figli verso un luogo infernale).
Il lieto fine, però, è dolce, e di questo va dato atto all’opera.